Indice dei contenuti
Quando pensiamo alle strade delle antiche città, spesso immaginiamo un mondo illuminato da fiaccole che ardevano tutta la notte. Tuttavia, secondo Nuisia Raridi, docente di storia e divulgatrice sui social, questa idea è frutto di una rappresentazione cinematografica più che della realtà storica.
Di notte c’era buio pesto
Nei suoi video, Raridi spiega che la notte nell'antichità era sinonimo di oscurità assoluta. "Siamo abituati da decenni di film a vedere strade illuminate da fiaccole, ma nella realtà era ben diverso", afferma. Le città, una volta calato il sole, si spegnevano. Il motivo? I ritmi di vita erano molto diversi da quelli moderni. "Le persone comuni andavano a letto presto, poco dopo il tramonto, e si svegliavano prima dell'alba. La luce artificiale per strada non serviva quasi a nessuno", sottolinea l'esperta.
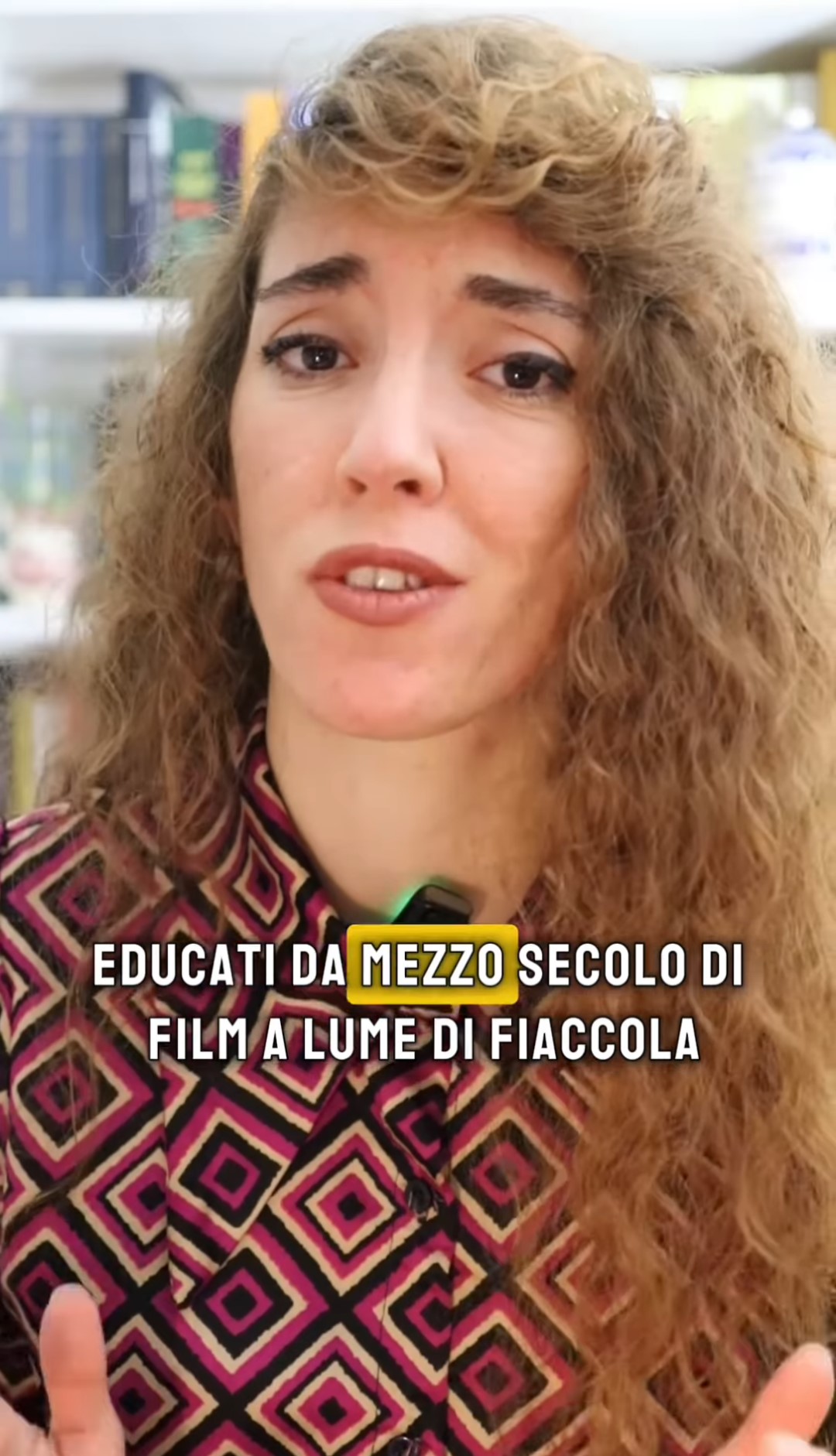
Inoltre, mantenere l'illuminazione pubblica era estremamente costoso. Candele e fiaccole consumavano risorse preziose e non aveva senso tenerle accese solo per rendere le strade più visibili. Proprio per questo, la notte era considerata pericolosa e dominata da ladri e malintenzionati. "Diversi autori dell'epoca sconsigliavano vivamente di mettersi in viaggio dopo il tramonto", aggiunge.
Roma: qualche eccezione alla regola
Nonostante il buio predominante, Roma faceva eccezione in alcuni punti della città. Qui, alcune luci restavano accese anche dopo il tramonto, ma con scopi ben precisi. "A illuminare la notte erano soprattutto le insegne di postriboli e locande, oltre alle fiaccole accese davanti alle immagini sacre", racconta Raridi.
Uno degli elementi più interessanti erano i lares compitales, divinità protettrici dei quartieri. Le loro immagini erano spesso collocate in edicole agli incroci e vi si accendevano fiaccole che rischiaravano più strade contemporaneamente. Questa tradizione, spiega la storica, non si interruppe con l'avvento del cristianesimo. "Con il declino del paganesimo, i lari furono sostituiti dai santi cristiani, ma le luci continuarono a splendere davanti alle loro immagini". Si presume che dessero un senso di protezione e sicurezza.
L’arrivo della luce pubblica e la nascita della vita notturna
L'illuminazione pubblica, come la intendiamo oggi, arrivò solo molto tempo dopo. Fino a quel momento, il buio era un elemento naturale della vita quotidiana. Con l'introduzione di lanterne pubbliche e, successivamente, di gas e elettricità, le città iniziarono a diventare più sicure. Questo portò alla nascita di nuove attività notturne, fino ad allora impensabili. "Solo con la luce artificiale la notte smise di essere sinonimo di pericolo e divenne uno spazio di socialità e lavoro", conclude Raridi.
Insomma, l'idea che le strade antiche fossero illuminate da fiaccole tutta la notte è un mito cinematografico. In realtà, la maggior parte delle città restava completamente al buio. L'autrice del video, usando un termine colorito, assicura che in passato le città erano avvolte nel buio pesto. Solo alcuni punti specifici, come locande e luoghi sacri, erano rischiarati da deboli luci. La vera rivoluzione arrivò solo con l'introduzione dell'illuminazione pubblica, che trasformò le città e la vita delle persone. La stessa docente di storia, di recente, ha parlato di come si combatteva il freddo nel Medio Evo.
Visualizza questo post su Instagram

