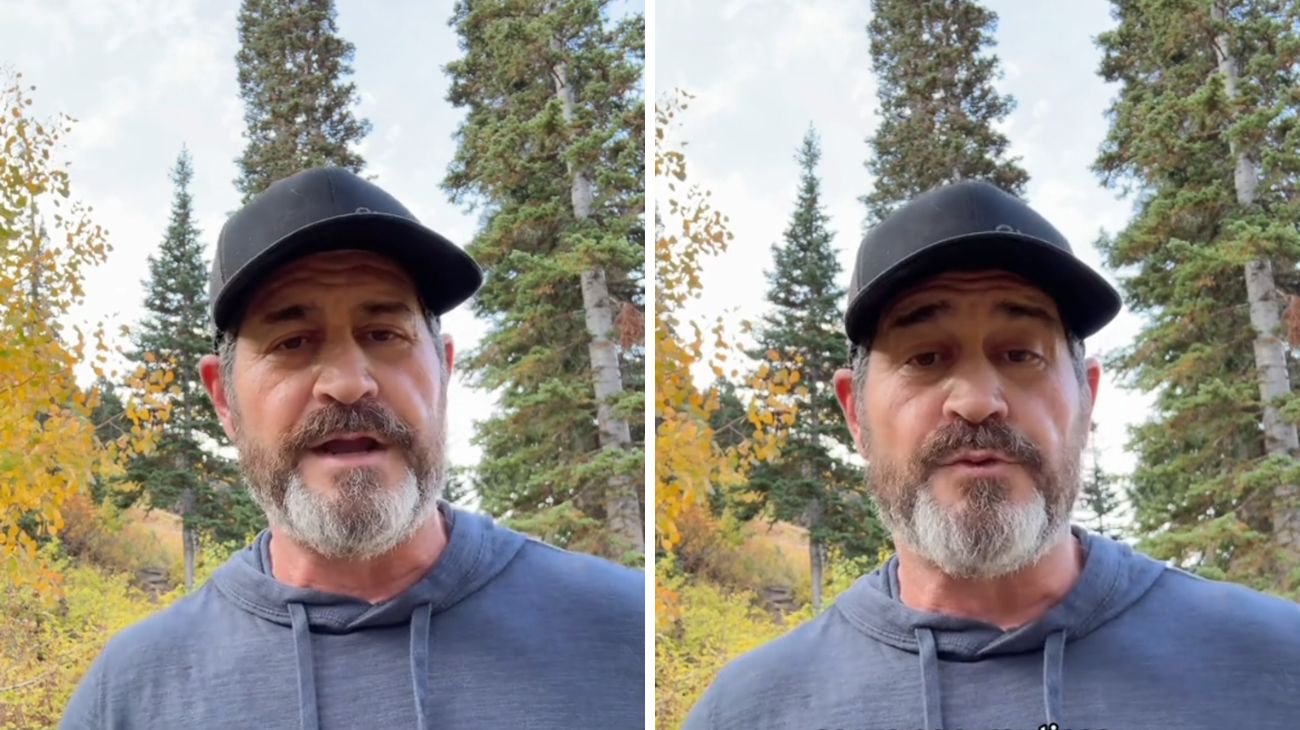Indice dei contenuti
Perché, quando invecchiamo, ci sembra che il tempo scorra più veloce? La domanda riemerge puntuale a fine mese: sembrava ieri Capodanno e, all’improvviso, siamo già alle ultime ore di settembre. Lo abbiamo detto tutti, o l’abbiamo sentito dire da un amico, un parente o uno sconosciuto. Anche il medico statunitense @drjeremylondon, in un video virale, ha rotto il ghiaccio con una battuta: “La vita è come un rotolo di carta igienica: più ti avvicini alla fine, più rapidamente si esaurisce”. Oltre lo spirito, c’è una spiegazione psicologica precisa che la ricerca ha discusso per oltre un secolo: la teoria proporzionale del tempo soggettivo e l’effetto della novità sulla memoria.
Tempo soggettivo e teoria proporzionale: perché gli anni “accorciano”
Il punto di partenza è la proposta del filosofo francese Paul Janet (1877): la velocità apparente del tempo cresce in proporzione all’età di chi giudica. In altre parole, a 10 anni un anno equivale al 10% della vita vissuta; a 50 anni, quello stesso anno pesa appena il 2%. Una “fetta” sempre più sottile, che la coscienza registra come un’accelerazione. La traduzione e il commento moderno di questa idea compaiono nella rivista Time & Mind, che riprende integralmente il testo di Janet e ne discute l’attualità neuroscientifica (Brill).
La proporzionalità non significa che gli orologi corrano davvero: cambia la nostra metrica interna. L’unità “anno” perde salienza man mano che il denominatore—la vita totale vissuta—si allarga. Questo schema, semplice ma potente, ha orientato molte interpretazioni successive sul perché dopo i 30–40 anni il tempo sembri scivolare più in fretta.
Novità, memoria episodica e routine: come il cervello comprime il tempo
La proporzione da sola non basta. Conta come immagazziniamo gli eventi. La psicologia cognitiva mostra che la novità dilata il tempo percepito: stimoli nuovi o “oddball” vengono vissuti come più lunghi rispetto a quelli ripetuti, perché richiedono più risorse di codifica e attirano l’attenzione. Una rassegna teorica di David Eagleman e Vani Pariyadath spiega che la durata soggettiva è legata all’efficienza di codifica: ciò che si ripete viene compresso, ciò che sorprende si espande (Philosophical Transactions B, 2009). Il fenomeno è documentato anche nel paradigma dell’oddball effect (Journal of Vision; Springer).
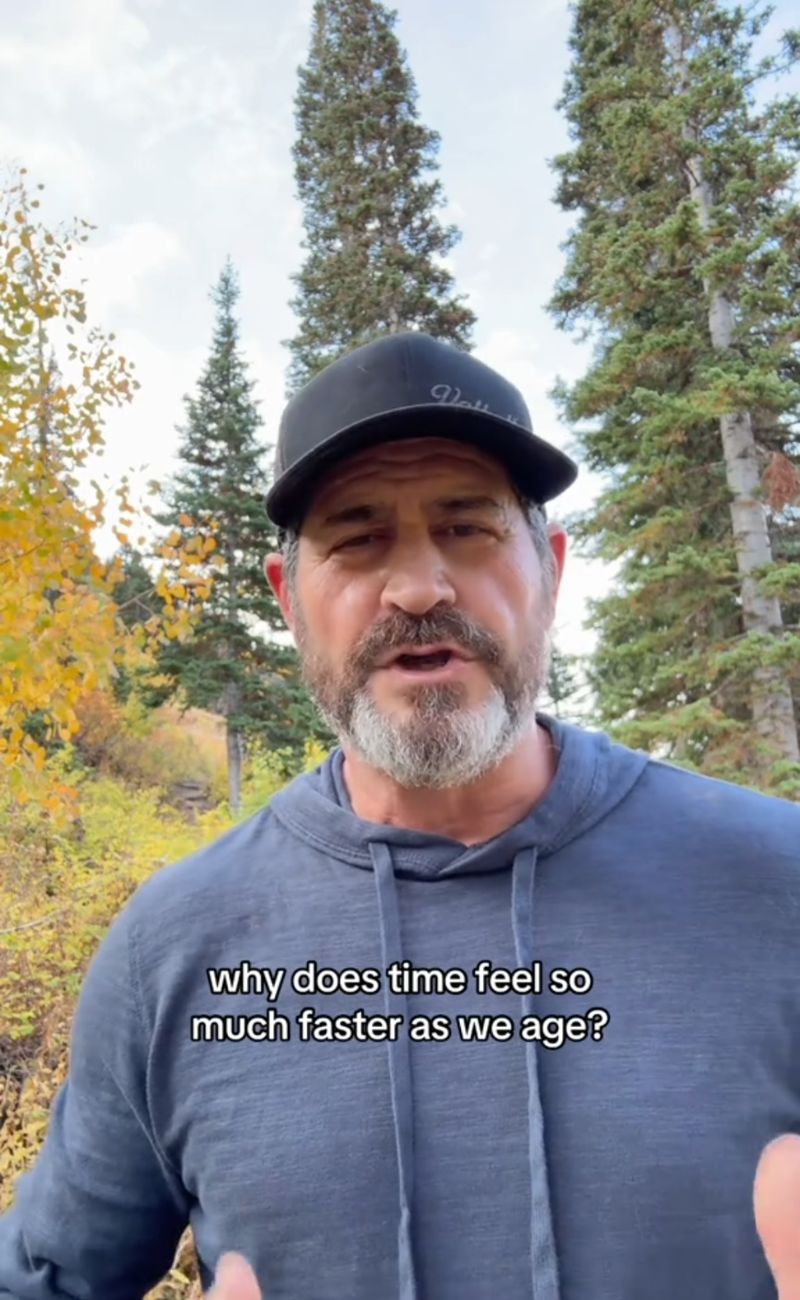
Nel quotidiano, l’effetto si traduce così: infanzia e adolescenza abbondano di prime volte—prima scuola, primi amici, primi viaggi—e ogni episodio, essendo denso di novità, apre ricordi nitidi che riempiono la memoria. In età adulta prevale la routine, che riduce la segmentazione degli eventi e rende le settimane simili tra loro. La Event Segmentation Theory mostra che quando il cervello identifica confini tra eventi li ricorda meglio; con routine ripetitive quei confini sfumano e, a posteriori, i periodi sembrano “collassare” (Trends in Cognitive Sciences; Kurby & Zacks, 2008).
Dalla tradizione a oggi: da William James a Marc Wittmann
Già William James, alla fine dell’Ottocento, rifletteva sull’esperienza del tempo, distinguendo tra “presente apparente” e continuità del flusso cosciente, un’analisi che ha ispirato la psicologia successiva (Principles of Psychology, 1890). In tempi recenti, lo psicologo Marc Wittmann ha sintetizzato prove psicologiche e neuroscientifiche nel volume Felt Time (MIT Press): con l’età, l’aumento delle abitudini e la minore densità di esperienze inedite porterebbero a un’accelerazione del tempo vissuto; al contrario, una vita “varia e piena” tende a dilatarlo (MIT Press; ed. paperback).
Quando un divulgatore come @drjeremylondon spiega che “a 10 anni un anno vale il 10% della vita, a 50 il 2%”, riprende in modo pop l’intuizione di Janet e la integra con ciò che sappiamo su attenzione, memoria episodica ed effetto novità. Funziona perché risuona con la nostra esperienza: le estati dell’infanzia sembravano infinite; quelle adulte volano.
Dopo i 30 anni cambia davvero? Cosa mostra l’esperienza (e cosa no)
Non esiste uno “scatto” a 30, 40 o 50 anni: la sensazione cresce gradualmente. Molti riportano, già dopo l’università, che mesi e anni scorrono più rapidi. Il motivo non coincide con il metabolismo degli orologi, ma con l’organizzazione della vita: lavori più stabili, rituali ripetuti, numero decisamente minore di “prime volte”. Quando, invece, si attraversano fasi nuove—un trasloco, la nascita di un figlio, un viaggio lungo, l’apprendimento di una lingua—le giornate si allungano nella memoria. È la combinazione tra proporzionalità (Janet) e densità di eventi (Eagleman, Zacks) a modulare il nostro calendario interiore.
Come “rallentare” il tempo percepito: strategie pratiche (validate dalla psicologia)
Non si tratta di fermare le lancette. Possiamo però agire su attenzione, novità e memoria per dare più “spessore” alle giornate:
- Programma novità regolari: inserisci micro-prime volte ogni settimana (un percorso diverso per andare al lavoro, un museo, un corso breve). La novità rafforza la codifica e dilata la durata vissuta (Eagleman & Pariyadath, 2009).
- Segmenta gli eventi: crea confini riconoscibili nella routine (inizio/chiusura intenzionali delle attività, diari con snapshot della giornata). Migliora la memoria episodica e riduce la “fusione” delle settimane (Zacks et al.).
- Allena l’attenzione: pratiche brevi di mindfulness aumentano la consapevolezza del momento e, secondo Wittmann, rallentano la velocità soggettiva della vita (Wittmann, MIT Press).
- Impara qualcosa da principiante: lingue, strumenti musicali, abilità manuali. Il cervello investe risorse extra quando “non sa ancora come fare”, e l’esperienza si dilata.
- Viaggia con intenzione: non solo spostarsi, ma curare la varietà di contesti e incontri. Più confini episodici = ricordi più ricchi.
Alla domanda iniziale—è vero che dopo i 30 il tempo passa più veloce?—la psicologia risponde con sfumature: la velocità percepita aumenta mano a mano che l’unità “anno” diventa una porzione minore della vita (Janet) e che la routine, se non bilanciata da novità, comprime i ricordi. Per “rallentare”, torna principiante ogni tanto. Anche il rotolo, per citare la battuta del medico, si usa con più calma quando non lo si spreca tutto uguale.