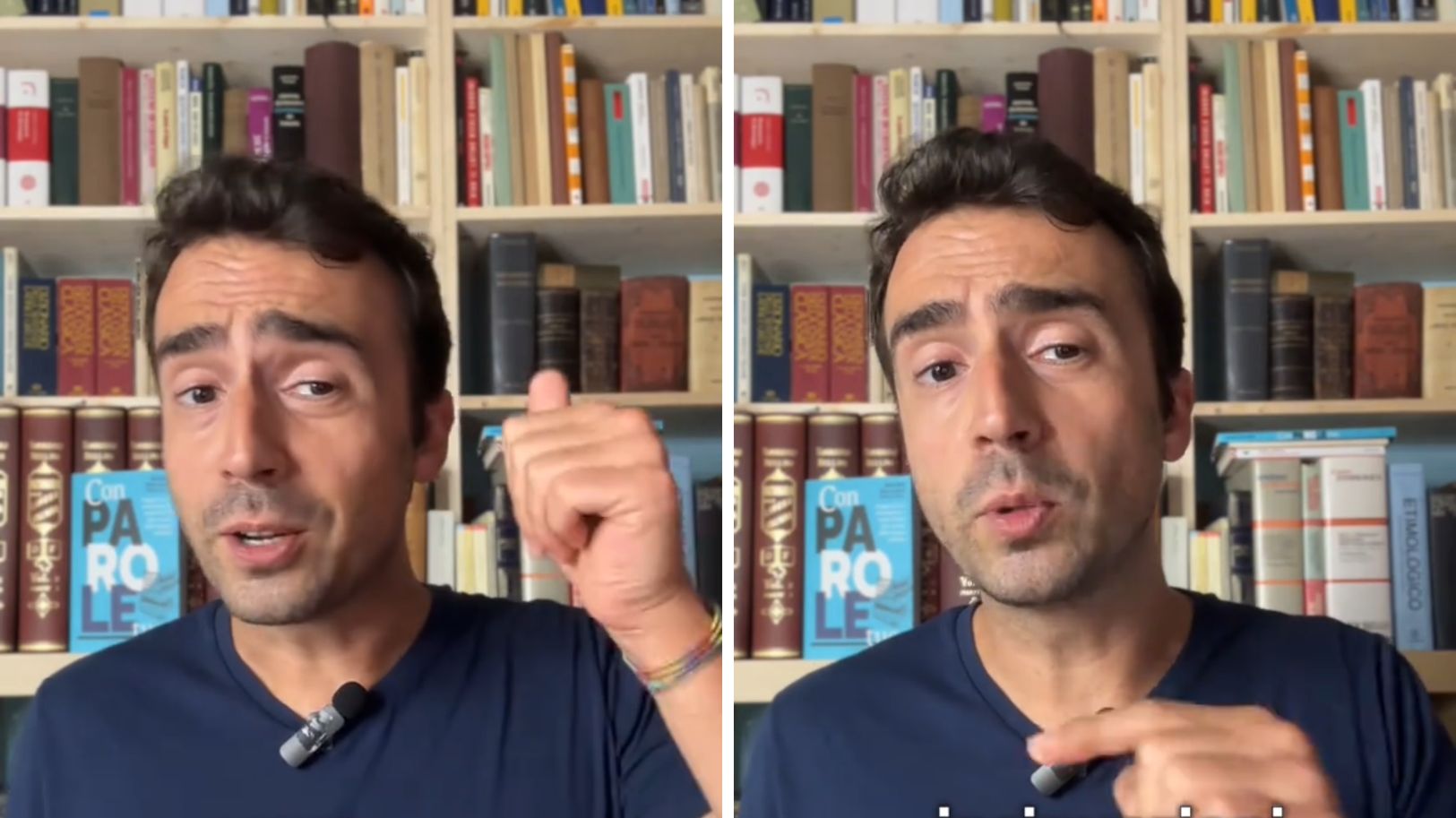Indice dei contenuti
Pettegolo o pettegola è una parola che usiamo per identificare chi racconta i fatti privati altrui, spesso aggiungendo insinuazioni e giudizi. L’etimologia, però, racconta anche perché questo comportamento veniva percepito come qualcosa di sgradevole, quasi “fisico”. Il linguista Marco Ballarè ha ricordato che il termine italiano discende dal veneto petégolo (o petégoła nella forma femminile), collegato a peto, letteralmente piccolo peto. l’immagine è chiara, chi sparge chiacchiere “lascia in giro” piccoli, maleodoranti spifferi. Una metafora robusta, che rende l’idea di una loquacità incontrollata e maliziosa
Etimologia di “pettegolo”: dal veneto petégolo al collegamento con “peto”
Le principali opere lessicografiche confermano quanto riportato dal linguista: Treccani fa risalire pettegolo «al ven. petégolo, derivato di peto, per allusione all’incontinenza verbale», cioè a una parlantina che sfugge di mano proprio come un peto. Anche il Nuovo De Mauro registra la voce e ne attesta l’uso almeno “av. 1556”, con spiegazione analoga sul legame al rumore sgradevole del chiacchiericcio. Questi dettagli non abbelliscono soltanto la storia della parola: spiegano perché in passato pettegolo suonasse più offensivo di oggi, carico com’era di un’immagine corporea e ridicolizzante.
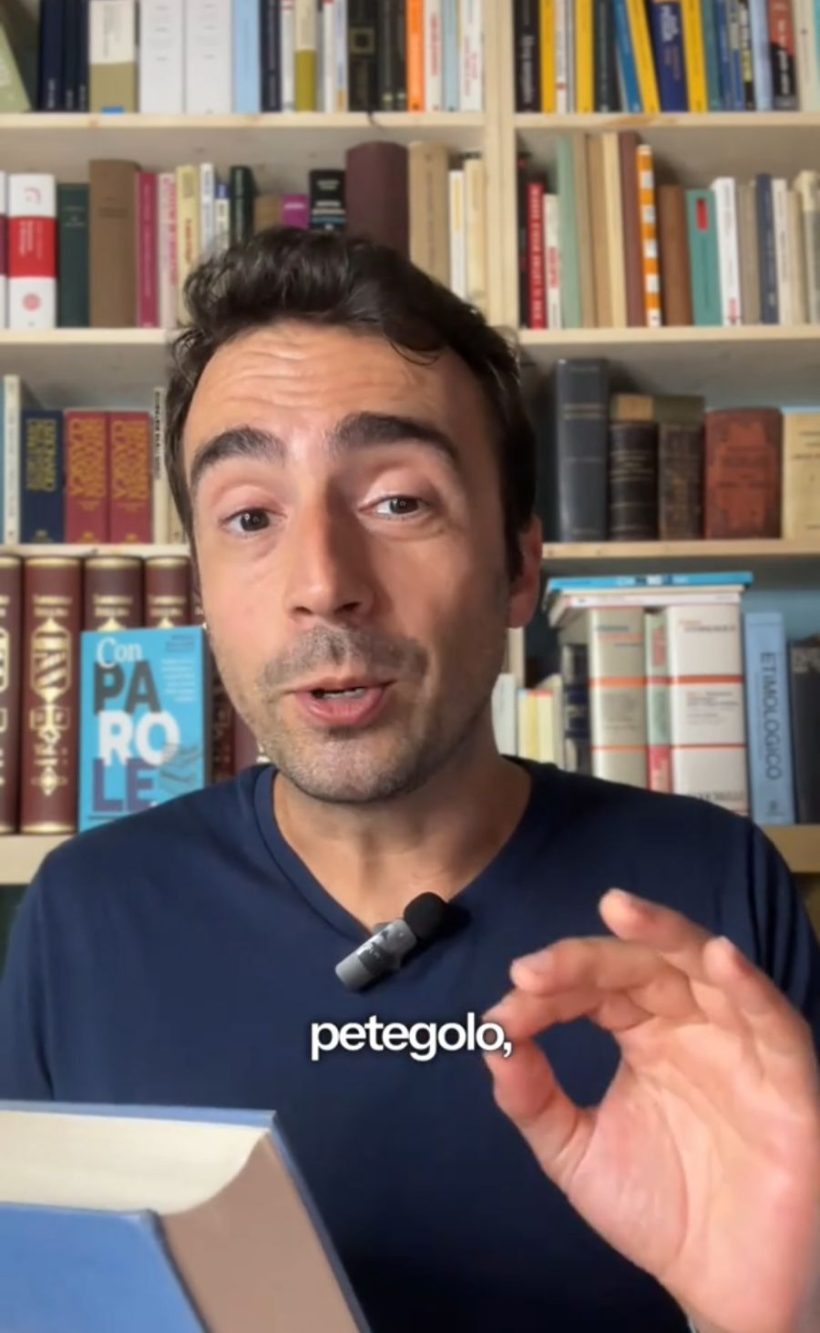
Lo stesso collegamento emerge in altre risorse etimologiche e divulgative ben note ai lettori, che ribadiscono l’origine veneta e la metafora dell’“incontinenza” applicata alla lingua. L’italiano ha poi ereditato l’intera famiglia: pettegolezzo, spettegolare, pettegole. Quando usiamo questi derivati, rafforziamo quell’antica sfumatura di frivolezza maleodorante attribuita alla chiacchiera inutile.
Perché un tempo suonava più insultante
Nel sistema sociale premoderno, la reputazione valeva quanto—e talvolta più—del patrimonio. Chi “spandeva” storie private comprometteva la coesione del gruppo. Non stupisce che l’italiano standard, quando accoglie pettegolo dal veneto, lo faccia già marcato da un’immagine disgustosa: il peto per antonomasia non si nomina, si lascia. Dare del pettegolo significava quindi accusare l’altro di maldicenza e indiscrezione, ma anche di maleducazione. I dizionari moderni lo segnalano ancora: “chi fa chiacchiere indiscrete o maliziose”. Oggi l’insulto si è attenuato; rimane però riconoscibile, soprattutto quando accompagnato da contesti di diffamazione o di calunnia.
Ballarè, con una battuta che ha il sapore della glossa etimologica, aggiunge: “Spettegolare potrebbe anche essere divertente, ma è meglio non esagerare, per evitare di essere accusati di incontinenza”. Un monito che riecheggia la tradizione lessicale: parola leggera, effetti pesanti.
E l’imprecazione “mannaggia”?
Per par condicio, prendiamo un'espressione colloquiale italiana nata al Sud: mannaggia, l’imprecazione che in tutta Italia esprime disappunto. Qui le fonti autorevoli concordano su un’origine meridionale e offrono due piste principali: la contrazione di mal n’aggia (“male ne abbia”) e la variante malannaggia (“abbia un malanno”, letteralmente “un anno cattivo”). L’Accademia della Crusca, nella consulenza firmata da Giuseppe Patota, illustra bene la storia della formula; il Vocabolario Treccani ne registra significato ed etimologia in linea con queste ricostruzioni.
Chi oggi dice “mannaggia” lo fa come interiezione blanda, più colorita che violenta. Nel passaggio all’italiano comune l’imprecazione si è generalizzata: dal malaugurio mirato (che “qualcuno ne abbia male”) a un semplice sfogo emotivo. Non si tratta di “uso improprio”, come osserva qualcuno: è la normale evoluzione semantica di una parola che, spostandosi di contesto e registro, si è resa più maneggevole nella conversazione quotidiana. La lessicografia contemporanea conferma proprio questa diluizione del valore maledicente.
Parole, immagini e società: perché queste etimologie parlano di noi
Origine di “pettegolo” e origine di “mannaggia” mostrano due direzioni tipiche del lessico: da un lato la metafora corporea che stigmatizza la chiacchiera come “peto” verbale; dall’altro la maledizione attenuata che, viaggiando dal Sud all’uso nazionale, perde asprezza e diventa intercalare. Nelle parole, insomma, rimane traccia di ciò che una comunità valuta, tollera, condanna. I social accelerano questo processo: un commento frettoloso può trasformarsi subito in pettegolezzo, mentre un “mannaggia” sotto un post stempera il tono senza scatenare faide linguistiche.